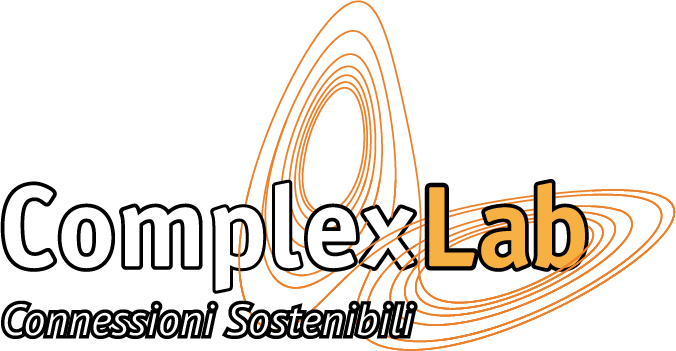Corporate Social Responsability ed economia sostenibile
[ pubblicato sulla rivista on –line Altalex ]
La Commissione Europea con la comunicazione 136 del 22 marzo 2006 al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo ha posto l’obiettivo di fare dell’Europa “un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese”.
L’economia di mercato per restare competitiva nel lungo termine deve potere integrare il successo economico con la coesione sociale e la protezione ambientale, acquista pertanto importanza il dialogo con gli stakeholder al fine di gestire le problematiche sociali e ambientali che influenzano la competitività delle imprese. L’autoregolamentazione, in particolare delle maggiori aziende, dovrà creare un clima di equità e fiducia da affiancarsi ad un sistema legislativo e normativo efficace.
Al riguardo vi è molto scetticismo per l’ipercompetitività dei mercati, con conseguente pressione sui costi e la ricerca di nuove opportunità di crescita, circostanza che ha indotto molte imprese a comportamenti opportunistici se non fraudolenti perdendo di vista la necessità del mantenimento di condotte finanziarie e sociali più equilibrate nell’interesse strategico dell’impresa stessa, superando il tatticismo del breve termine.
Già nel 2002 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha lanciato un progetto ( Corporate Social Responsability – Social Committment) relativo alla diffusione della cultura di CSR su base volontaria.
La nuova visione strategica del successo aziendale punta a integrare nel progetto imprenditoriale le istanze sociali e ambientali, interagendo direttamente con i vari interlocutori.
Dobbiamo superare la visione di un mercato senza regole in cui primeggino esclusivamente i profitti, sacrificando qualsiasi responsabilità sociale delle imprese, con particolare riguardo a quelle medio – grandi, se è vero che i programmi di CSR sono visti dalle imprese in molti casi in termini puramente difensivi rispetto alle sfide di settori consapevoli sempre più ampi della società, è anche vero che è stata sottolineata da più parti la necessità di un nuovo approccio strategico basato su un nuovo contratto sociale (Donaldson, Dunfee); questo ancor più di fronte alle nuove crisi ecologiche e sociali che si stanno manifestando secondo un concetto di pura crescita economica e non di sviluppo.
La CSR non è altro quindi che l’integrazione degli obiettivi economici, ambientali e sociali nel rispetto dei rispettivi ruoli tra l’impresa e i vari stakeholder (Freeman), secondo un concetto di gestione integrata.
Si è detto che nel lungo periodo gli interessi degli azionisti e degli altri stakeholder si integreranno, ma questo avverrà solo a seguito di una chiara visione e corretta azione del management.
La responsabilità sociale dell’impresa comporterà un miglioramento dell’immagine sociale e della gestione delle risorse umane, per tale via una conseguente contrazione dei costi per l’accesso alle risorse finanziarie e a un miglioramento dei costi di produzione e della qualità e appetibilità del prodotto, questo comporta la necessità di sviluppare un concetto di governance strategica integrato tra le dimensioni economiche, sociali e ambientali, incrementando le risorse immateriali della fiducia e delle relazioni positive per uno sviluppo sostenibile nel tempo.
Si tratta di una mentalità che non può formarsi solo in termini burocratico - normativi, ma dovrà essere assimilata dal management convinto della sua bontà.
La necessità nelle economie avanzate di uno sviluppo sostenibile nel tempo, con una ampia responsabilità sociale, che superi il puro aspetto quantitativo iniziale, lo si può riscontrare anche dall’esame dell’undicesimo Piano Quinquennale (2006 – 2010) di Pechino.
Si parla di “sviluppo scientifico” con cui superare il puro “sviluppo estensivo”, passando da una crescita a ogni costo ad uno sviluppo sostenibile e si afferma chiaramente che la crescita economica non è da identificarsi con lo sviluppo economico. La crescita economica a qualsiasi costo, fuori da progressi tecnologici e innovazione ha portato a gravi danni ambientali e non si è riversata automaticamente su un progresso sociale generale, favorendo forti squilibri sociali che se non opportunamente corretti porteranno in un prossimo futuro a tensioni faticosamente gestibili.
Si introduce il concetto “prosperità condivisa”, in cui dall’iniziale “arricchirsi è giusto” di Deo Xiaoping si punta ad un bilanciamento dell’economia di mercato con la ricerca dell’egualitarismo quale base della direzione della crescita, dando maggior ruolo alla legalità, alla difesa della giustizia e alla stabilità sociale.
L’analisi economica tradizionale pone un legame diretto tra benessere materiale e felicità, intesa come benessere soggettivo derivante dalla qualità della propria vita, anche se riconosce un rapporto decrescente all’aumentare del reddito in quanto la crescita dello stesso procura maggiore felicità in un individuo povero.
Ronal Inglehart ha evidenziato che ciascun individuo conferisce un maggiore valore alla risorsa che a lui appare più scarsa, si che si passa progressivamente da acquisizioni di beni materiali a beni immateriali quali il tempo libero per l’auto-espressione secondo “valori post – materialisti”.
Proprio con l’uscire dalle esigenze materiali immediate si arriva ad assegnare maggiore valore alla qualità della vita cercando di perseguire stili di vita diversi.
Si afferma in parallelo un modello di “economia della conoscenza” nella quale il bene economico maggiore risiede nella creatività, ossia nella capacità di interloquire con gli altri le proprie esperienze. All’inizio questo può comportare una dicotomia tra diritti di proprietà e diritti di libertà, i primi intesi come tutela del controllo dei mezzi di produzione, i secondi come sostegno alle capacità innovative, anche se successivamente la stessa innovazione tenderà ad essere tutelata dai diritti di proprietà.
Ma sorge anche un altro problema sociale la necessità di integrare le capacità creative individuali in un rapporto ordinato e coerente con gli altri, in modo da ottenere la prevedibilità dei comportamenti in un continuo dilemma autonomia / controllo (Melucci).
L’economia della conoscenza non è altro che la premessa necessaria ad una economia sostenibile in cui il PIL non può essere più inteso come indicatore assoluto della crescita, in quanto non sottrae né l’impoverimento del capitale naturale ad opera dell’uomo, né il deprezzamento nel tempo del capitale già prodotto dall’uomo.
Gli economisti ecologici hanno pertanto introdotto nelle analisi, dopo una serie di aggiustamenti positivi e negativi, l’Indice di benessere economico sostenibile (ISEW) sviluppato da Clifford W. Cobb e John B. Cobb Jr., in cui si considera tra l’altro il concetto di “disutilità” come crescita antieconomica, ossia “futile”, nella quale l’aumento dei consumi non aggiunge alcuna utilità rispetto al sacrificio necessario per ciascuna unità di consumo in più.
Forse il malessere di molta parte della nostra gioventù è sintomo di questo stadio economico a cui le nostre economie avanzate sono giunte.
Non più la crescita quantitativa ma quella qualitativa, ossia lo sviluppo può essere la risposta a cui una impresa socialmente responsabile può dare un grosso contributo, consolidando il rapporto con un mercato sempre più qualitativamente esigente, in presenza di risorse ambientali sempre più scarse.
Bibliografia
- Herman E. Daly, L’Economia in un mondo pieno, in “Le Scienze”, 112 – 119, 11/2005;
- Cobb. C. W. e Cobb J. B. jr., The Green National Product: A Proposed Index of Sustainable Economic Welfare, University Press of America, 1994;
- Di Gianni Silvestrini, Verso la fine del Petrolio, in “Le Scienze”, 80 – 85, 11/2005;
- Di Marco Cattaneo, Siamo arrivati alla resa dei conti, in “Le Scienze”, 38 – 39, 11/2006;
- M. Weber, Crescita armoniosa e sviluppo sostenibile: le linee guida di Pechino, in “Economia & Management”, 30 – 34, ETAS, 1/2006;
- F. Perrini, Corporate Social Responsability: l’Europa e lo sviluppo di imprese competitive e sostenibili, in “Economia & Management”, 11 – 17, ETAS, 3/2006;
- F. Perrini, Corporate Social Responsability: nuovi equilibri nella gestione di impresa, 7 –13, ETAS, 2/2006;
- R. Inglehart, La società postmoderna. Mutamento, ideologie e valori in 43 paesi, Editori Riuniti, 1998;
- A. Melucci, Libertà che cambia. Una ecologia del quotidiano, Edizioni Unicopoli, 1987;
- T. Donaldson – D. Dunfee, Ties that Bind. A social Contracts Approach to Business Ethics, Harvard Business School Press, Cambridge, 1999;
- A. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984.