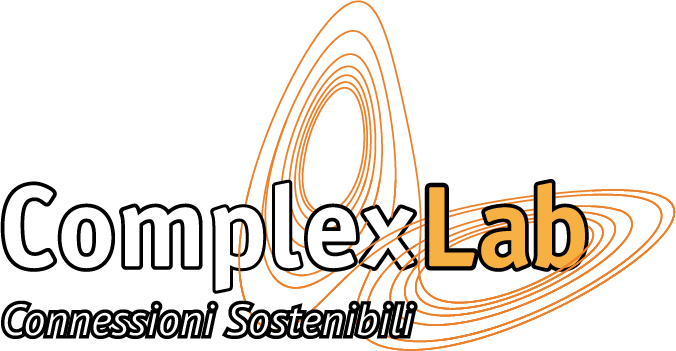Riflessi economici di sapienza, saggezza e tecnicità.
Aristotele distinse per la prima volta la sapienza dalla saggezza, fino a Platone i due termini indicavano semplicemente la condotta razionale della vita umana, cioè la saggezza.Aristotele individua nella sapienza il grado di conoscenza più alto, pertanto più certo e più completo, degna delle cose più eccellenti. L’oggetto specifico della sapienza è quindi il necessario, quello che non può essere altrimenti e può sfociare nelle filosofie contemplative, lontane dalle filosofie pratiche che si interessano del comportamento razionale dell’Uomo in ogni campo e di ciò che è bene o male per l’Uomo, ossia della saggezza nella condotta.
Questa distinzione può sfociare in un distacco assoluto dalle umane vicende, come già osservato da Dewey, confermando per tal via l’esistente, ma può anche fondare l’essenza delle scienze naturali. Cartesio e Leibniz uniscono l’aspetto teoretico all’aspetto pratico e nell’includere l’aspetto pratico rifiutano l’ideale della sapienza come sfera superiore e staccata dalle problematiche umane, fino a giungere con Hegel e Schopenhaur ad assolutizzare il carattere umano e mondano della saggezza (saggezza mondana), intendendo per essa l’arte di trascorrere la vita nel modo più felice possibile.
La sapienza in termini moderni è stata ripresa da W. James come sapere, secondo la distinzione tra conoscere una cosa, come semplice familiarità con questo oggetto, e avere una conoscenza magari circoscritta ma scientificamente esatta, circostanza già descritta da J. Grote.
Russell distingue tra esperienza diretta e conoscenza circa, ossia fra le cose che ci sono immediatamente presenti e quelle che noi raggiungiamo solo per mezzo di frasi detonanti, ma il sapere può essere visto anche come scienza, conoscenza in qualche modo garantita nella sua verità, significato che solo in apparenza è contrapposto agli usi di James e Russell in quanto parte di essi.
In questo dibattito si pone l’Uomo come auto-progettazione possibile, visione sostenuta sia dall’esistenzialismo che dallo strumentalismo americano, i quali sostengono che l’Uomo è costantemente problema a se stesso e contemporaneamente sua soluzione, che egli progetta e crea il suo modo di vivere realizzandolo. La progettualità è tuttavia limitata dagli stessi dati di cui si avvale, pertanto il passato condiziona entro limiti più o meno estesi il futuro dell’Uomo.
Come sostenuto dall’esistenzialismo positivo, l’evoluzione di per sé non ha alcuno scopo è l’Uomo che deve dare uno scopo a se stesso (Dewey, Simpson), anche se l’Uomo, come espressione dell’autocoscienza della natura, può tuttavia vedersi quale suo strumento.
In questi termini interviene il tecnicismo, ossia la riduzione della saggezza nella conoscenza tecnica della manipolazione della natura, ai fini economici l’unico aspetto culturale che interessa, risultando addirittura pericoloso in termini di manipolazione del marketing la formazione dell’uomo secondo l’antico modello di saggezza, ossia valutazione di ciò che è bene o male per esso.
Questo risulta funzionale ai modelli attuali di istruzione che si riducono in molti casi ad aspetti puramente tecnici, saltando la formazione critica della personalità nel suo complesso, circostanza senz’altro favorita dalla riduzione della qualità per il crescere della massa e dalla necessità di contenere le risorse immesse nel sistema. La riduzione tecnicistica si trova a qualsiasi livello di istruzione, dalle superiori all’università, favorita dalla frantumazione del sapere e quindi di riflesso dello spirito dell’Uomo, trasformato in puro elemento meccanico smontabile e ricomponibile, quindi economicamente valutabile.
La forma unitaria dell’ essere si ricrea in termini elitari, come qualcosa che spetta esclusivamente per costi e sforzi ad una fascia ristretta.
Nota
• N. Abbagnano, Storia della filosofia, Utet, 1974