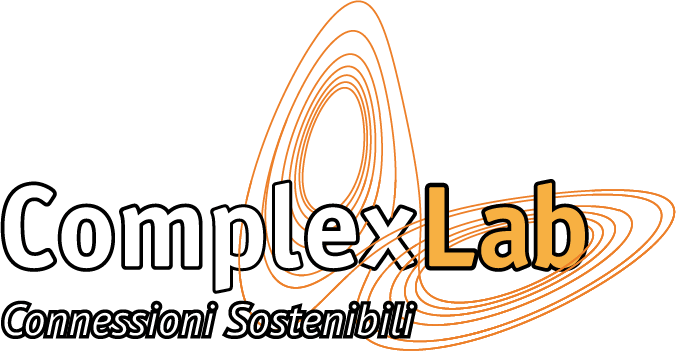[ per un efficace e breve approfondimento della teoria della complessità: Cos'è la complessità... semplicemente? - NdR ].
1. Discutere di “complessità” è stato a lungo avvertito come un obbligo irrinunziabile: nessuno che ambisse a una certa visibilità in alcuni dibattiti epistemologici del secolo scorso poteva illudersi di farne a meno. Il panorama culturale italiano dei primi anni ottanta offre una serie di esempi che confermano questa tendenza generale: risale al 1984 la pubblicazione, presso un autorevole e prestigioso editore milanese, di un’antologia di scritti emblematicamente intitolata La sfida della complessità. Di qualche anno prima invece è l’uscita di un numero monografico della rivista “Le scienze”, La matematica della complessità, che ha come obiettivo programmatico il chiarimento delle radici e delle applicazioni matematiche di questo singolare concetto. Animato, per un verso, dalla implicita, oltre che legittima, preoccupazione di ricondurre ogni discorso sull’argomento a una solida base scientifica, La matematica della complessità diventa, per un altro, caso esemplare (e a dir poco sintomatico) di una consuetudine terminologica che avrebbe di lì a poco dilagato in numerosi ambiti disciplinari. Una lettura superficiale dei titoli all’epoca circolanti in Italia e nel resto dell’Europa chiarisce la natura di questo particolare fenomeno: nel giro di pochissimo tempo, la locuzione “della complessità” si trasforma in un complemento di specificazione universalmente impiegato. Complici figure di spicco come Morin (per le scienze umane), Prigogine (per le scienze fisico-matematiche), Atlan (per la biologia e la teoria dell’informazione) e Venturi (per l’architettura), l’uso di questo complemento si diffonde a macchia d’olio divenendo ben presto un’acquisizione del senso comune. L’obbligo, in altre parole, si era trasformato in una moda culturale.
2. Il 1995 segna una brusca battuta di arresto per la comunità dei “complessologi”. La rivista Scientific American – di cui Le scienze è l’edizione italiana – pubblica un articolo dal titolo tanto ironico quanto evocativo: From complexity to perplexity (FCP). L’autore, il giornalista scientifico John Horgan, vi denunziava l’assenza di univoci criteri d’identità che permettessero di stabilire cosa è complesso e cosa invece non lo è. La principale mossa teorica di Horgan a sostegno di questa posizione polemica si materializzò nella stesura di una lista di definizioni contenente differenti accezioni di “complessità”[1]. Lo scopo di questa lista era duplice: da un lato, mostrare il fallimento della comunità scientifica nell’assegnare alla parola “complessità” un significato ben determinato; dall’altro, suggerire il fallimento di un paradigma epistemologico che, pur presentandosi come un’autentica rivoluzione scientifica, si rivelava incapace di soddisfare i requisiti minimi che la scientificità impone: l’univocità e il rigore delle definizioni. La conclusione di Horgan era chiara: parlare di “complessità”, in assenza di univoci criteri d’identità, è solo un esercizio retorico che non produce conoscenza effettiva. Il passo verso lo slogan che per tanto tempo sarebbe riecheggiato nelle bocche di molti fu breve:«Se non possiamo dirci complessi, possiamo (e dobbiamo) dirci perplessi sulla complessità».
3. Le ragioni di Horgan erano tuttavia vittime di un pregiudizio epistemologico che limitava notevolmente l’effettiva portata dei concetti in gioco. Si riteneva che un discorso scientifico sulla complessità dovesse necessariamente basarsi su pochi parametri di valutazione prefissati e che ognuno di essi dovesse restituire un’immagine della complessità al singolare, ossia un significato univoco di complessità. La lista di accezioni elaborata a sostegno di questo pregiudizio dimostrava esattamente il contrario. Il termine “complessità” poteva essere inteso e declinato in molti modi, giacchè molti erano i punti di vista e le prospettive da cui esaminarne i mutamenti semantici. Geometria dei frattali, fisica delle strutture dissipative, teoria qualitativa delle equazioni differenziali, teoria algoritmica dell’informazione, matematica degli automi cellulari e tante altre discipline affini mobilitavano (e mobilitano tutt’oggi) parametri eterogenei di complessità attestando così la costitutiva polisemia del termine. La mossa teorica di Horgan sembrava dunque ritorcersi contro se stessa: più che indebolire il paradigma della complessità o decretarne il fallimento, la lista di accezioni indicava la presenza di programmi di ricerca eterogenei per i quali i criteri di univocità definitoria proposti risultavano del tutto obsoleti. Di conseguenza un’immagine plausibile della complessità poteva solo essere un’immagine al plurale, ossia una rappresentazione che restituisse una rete di significati diversi legati da rapporti instabili o in via di formazione.
4. Il prezioso libretto di Ignazio Licata, Complessità. Un’introduzione semplice – d’ora in poi, CIS – si inserisce perfettamente in questo particolare ordine di idee. Decisamente contenuto nelle dimensioni – un centinaio di pagine di piccolo formato – il lavoro del fisico siciliano può essere letto come una lunga e articolata risposta al saggio di Horgan. Il nome del giornalista scientifico, a dire il vero, non ricorre mai nel testo; tuttavia, molte delle questioni esaminate in CIS ricordano, sia pure con spirito profondamente diverso, temi e argomenti di quel saggio. Un punto, in particolar modo, si presta a esser letto in stretta contiguità polemica con le principali assunzioni di Horgan: la proposta di una teoria della complessità estrema (TCE). Esaminerò i contenuti di TCE mettendo a fuoco tre nuclei tematici fondamentali intorno ai quali è costruito il tessuto argomentativo di CIS:
- La complessità come scienza dei comportamenti collettivi emergenti (SCCE)
- La complessità come apertura logica (AL)
- La complessità come management cognitivo (MG)
I nuclei individuati (SCCE, AL e MG) offrono una buona visione d’insieme dell’impianto generale dell’opera garantendo – indipendentemente dal percorso di lettura intrapreso – una descrizione puntuale delle sue principali linee d’argomentazione.
5. TCE è uno stile di spiegazione dei fenomeni complessi articolato su tre differenti livelli di analisi: a) un livello multi-fattoriale; b) un livello debolmente riduzionistico; c) un livello globale. Ogni singolo livello integra caratteristiche specifiche dei livelli rimanenti. Da questo punto di vista, TCE rappresenta un sistema di strategie epistemiche volte a descrivere aspetti particolari dei fenomeni esaminati.
È bene intendersi però sui termini adoperati: nessuna di tali strategie è direttamente impegnata sull’ontologia dei fenomeni; ossia, nessuna di esse pretende di rivelare come stiano effettivamente le cose in natura. «La natura – osserva cautamente Licata – […] non è né semplice né complessa, semplicemente è».[2] Si tratta, semmai, di strategie impegnate nella generazione di modelli (o filtri cognitivi) tramite cui ricostruire la logica evolutiva di qualcosa che risulta situato tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo: “la terra di mezzo”. La stessa locuzione “fenomeni complessi”, più che designare un tipo particolare di fenomeni, sembra riferirsi, nell’ottica promossa da CIS, a un modo particolare di vederli. Discutere di “complessità” significa, in questa prospettiva, ragionare su una particolare visione della realtà che condensa varietà di modelli differenti. Il livello di analisi che abbiamo chiamato “multi-fattoriale” si riferisce esattamente a questo genere particolare di operazioni: una visione complessa del reale è tale solo se essa è in grado di intrecciare produttivamente livelli di descrizione eterogenei che sappiano, a loro volta, restituire l’intreccio di regimi di organizzazione, regolarità di scala e dinamiche evolutive su cui proliferano i fenomeni della terra di mezzo. Il principale limite epistemologico di Horgan risiede nel non aver compreso il potenziale euristico di questo particolare intreccio. Non esistono criteri univoci di complessità perché la complessità dei fenomeni non può essere catturata – “zippata”, direbbe ancora Licata – dai parametri di un solo modello formale. Al contrario, occorrono più modelli, più punti di vista in competizione reciproca per cogliere la complessità dei fenomeni – là dove “complessità” si riferisce alla pluralità di comportamenti imprevedibili che un sistema può mostrare: «In un senso piuttosto tecnico, un sistema è complesso quando mostra una pluralità di comportamenti che per essere descritti richiedono più modelli».[3] Gli ultimi due livelli di analisi completano il quadro teorico entro cui è immersa TCE. Vediamo come.
6. Per anni si è parlato di “complessità” in opposizione a “riduzionismo”. L’opposizione, in sé e per sé, è corretta; tuttavia, senza adeguate integrazioni, rischia di essere troppo semplicistica – e, di conseguenza, errata. Il secondo livello di analisi su cui è articolata TCE suggerisce una soluzione interessante: l’adozione di un riduzionismo debole (o mereologico). Sebbene non siano esattamente questi i termini di CIS, l’idea generale che sta dietro questa particolare forma di riduzionismo – qualificata da alcuni come “debole” (Tagliagambe), da altri come “mereologica” (Emmeche) – è in linea con molte delle idee proposte nel volume. Essa risulta in particolar modo compatibile con quanto è asserito circa la conoscenza degli elementi che compongono un sistema qualsiasi. Questo tipo di conoscenza – sostiene Licata – costituisce un’acquisizione essenziale nella descrizione del sistema esaminato giacché permette di stabilire le parti che ne compongono la struttura fine. Si tratta però di un’acquisizione che va ridefinita (e superata) in funzione di una più ampia prospettiva teorica. Nel contesto di questa seconda prospettiva – corrispondente, grosso modo, al terzo e ultimo livello d’analisi di TCE – sono prioritarie, non le parti, bensì le interazioni globali tra le parti (o comportamenti collettivi) che plasmano l’unità processuale dei sistemi osservati: «L’idea essenziale è che questa complessità non è “zippabile” in un singolo modello formale, e richiede piuttosto una “strategia epistemica” nuova che integra il riduzionismo (è un passo importante sapere quali sono gli elementi costitutivi del sistema!), ma lo supera mirando alla descrizione dei comportamenti collettivi e globali».[4]
7. SCCE, in fondo, è una strategia epistemica che interfaccia i contenuti di queste due prospettive complementari. Consideriamo uno stormo di uccelli o un banco di pesci: due esempi privilegiati in letteratura. Sia l’uno che l’altro sono, in un senso ben preciso del termine, creature collettive: forme di vita che – lungi dall’essere localizzate su singoli individui isolati – risultano finemente distribuite tra più individui interagenti. Il riduzionismo mereologico permette di descrivere ognuna di tali creature come entità composite, ossia come unità composte da tante altre micro-unità. Queste descrizioni, di per sé, non ostacolano l’adozione di una epistemologia sistemica. Che uno stormo di gabbiani sia costituito da singoli volatili della stessa specie è un’idea perfettamente compatibile con il punto di vista secondo cui esso è portatore di proprietà non computabili (o deducibili) da proprietà localizzate sulle unità componenti. In altre parole: uno stormo è fatto di singoli volatili, ma nessuna unità isolata è in grado di replicare le azioni collettive di cui esso è capace. La regia di queste azioni spetta all’intelligenza dello stormo, non ai singoli gabbiani che ne fanno parte. Resta così confermato uno dei luoghi comuni più potenti e pervasivi della complessità: un intero è qualcosa di più che la somma delle sue parti. SCCE ha avuto il merito di precisare i contenuti di questo luogo comune mostrando entro quali limiti certe descrizioni riduzionistiche sono compatibili con stili di spiegazione di tipo emergentista o sistemico.
8. Il riduzionismo – così sembra suggerire CIS – non è, di per sé, né buono né cattivo: è una strategia epistemica come tante che funziona nei limiti di specifici domini di applicazione. Pone dei seri problemi quando è impiegato come filtro interpretativo universale del reale:«Il problema non è condannare o difendere il riduzionismo, ma considerare dove è applicabile con successo. Nella terra di mezzo […] i modelli riduzionistici, semplicemente, non funzionano più, o funzionano male».[5] Aggiungerei, in linea con i presupposti teorici di CIS, che è la lettura ontologica dei modelli riduzionistici a fare acqua da tutte le parti. Nel momento in cui si trasforma in una teoria della realtà – e peraltro nell’unica teoria possibile – il riduzionismo diventa un punto di vista semplicemente insostenibile. Ritorniamo ancora una volta alle nostre creature collettive. Secondo il riduzionismo ontologico, le proprietà di cui esse sono portatrici possono essere computate (o dedotte) da proprietà che sono localizzate su singole unità componenti. Questa previsione è giustificata dall’assunto metafisico secondo cui ogni creatura collettiva non è altro che la somma di tante micro-unità. Stormi, formicai, sciami, ma così anche eserciti, squadre di calcio o sofisticati agenti collettivi come aziende e istituzioni pubbliche, sono il risultato di semplici illusioni ottiche, epifenomeni che l’osservatore specializzato costruisce nel proprio laboratorio concettuale senza aggiungere nulla alla conoscenza delle singole parti di cui già dispone. L’intero è – nell’ottica del riduzionista ontologico – la somma delle sue parti.
9. Molte sono le armi teoriche che sono state impiegate nel corso degli anni per combattere questa particolare visione del reale. Si è parlato di causalità verso il basso per indicare che ogni creatura collettiva – lungi dall’essere un epifenomeno causalmente inerte – impone dei vincoli regolatori sulle proprie unità componenti. E si è parlato anche di non-linearità per indicare che la conoscenza di un sistema non si risolve nella conoscenza (locale e sequenziale) di tali componenti: un sistema, cioè, più che un aggregato di elementi, è un pattern d’interazioni che si articolano su più livelli integrati e secondo linee evolutive altamente imprevedibili. La macchina argomentativa di CIS adopera con intelligenza ognuna di queste armi ma compie anche un passo in più: immerge l’analisi dei sistemi in un contesto ecologico. Il progetto del riduzionista ontologico potrebbe funzionare solo in condizioni ideali di completo isolamento. Se fosse possibile tracciare un netto confine di separazione tra un sistema e l’ambiente circostante, probabilmente la conoscenza locale dei singoli elementi offrirebbe tutta la quantità d’informazione necessaria per gestire l’intero sistema. Ma le cose stanno diversamente: i confini tra sistema e ambiente – e, più in generale, tra sistema e sistema – sono fluidi, ossia costantemente ridefiniti in funzione di rapporti intra e inter-sistemici che non cessano mai di trasformarsi. Da qui il rigetto ragionato di ogni riduzionismo ontologico:
La cosa può anche essere considerata da un altro punto di vista: non possiamo isolare ciò che ci interessa del sistema dall’ambiente circostante. Questa è in effetti una situazione molto semplificata, al limite dell’irrealistico. Ancora una volta è il gioco dell’inter-relazioni tra elementi del sistema (variabili!) e ambiente circostante (dinamico, e non definito una volta per tutte da un confine netto!) che porta all’effettiva complessità del sistema, inattaccabile con un approccio divide et impera di tipo riduzionistico.[6]
La lettura ecologica dei sistemi pone le condizioni per un fitto e proficuo dialogo tra SCCE ed AL.
10. AL è una strategia epistemica che porta sino alle estreme conseguenze i principali assunti teorici di SCCE: la possibilità di un confronto dialogico tra le due strategie è così sin dall’inizio inscritta nelle articolazioni concettuali di TCE. I fenomeni della terra di mezzo rappresentano il dominio d’applicazione privilegiato di questo singolare confronto. Come si è visto a partire dal paragrafo 7, la terra di mezzo è popolata da una ricca varietà di creature collettive che possono differire notevolmente per aspetto e struttura. Tuttavia, esse risultano accomunate da una singolare logica evolutiva che ne costituisce, per così dire, il marchio di riconoscimento universale. AL è il dispositivo epistemico deputato a precisare i contorni di questa logica particolare. La nozione di “accoppiamento strutturale” – termine chiave della riflessione sui sistemi autopoietici – è scelta da CIS come accesso privilegiato all’esame di tale logica. Sotto AL cadono, infatti, tutti quei sistemi che risultano fortemente accoppiati con l’ambiente e che, in virtù di reciproci rapporti di co-determinazione (intra e inter-sistemici), rimodulano di continuo i flussi informazionali interni e i regimi di organizzazione correlati. Dettaglio non trascurabile: nel contesto di AL, i processi che accompagnano la trasformazione dei flussi informazionali non sono riconducibili a nessuna procedura algoritmica codificata. Ancora una volta quindi saremmo in presenza di comportamenti collettivi che non possono essere zippati in un solo modello formale:
Userò il termine apertura logica per indicare quei sistemi in cui cambia continuamente l’informazione e la sua organizzazione interna in modo non algoritmico. Proprio quello che accade quando abbiamo a che fare con i processi della “terra di mezzo”: non possono essere zippati in un sistema di definizioni, perché sono sistemi che si evolvono, ricchi di biforcazioni e possibilità che non possono essere calcolate a priori; sono sistemi fortemente accoppiati con l’ambiente, che traggono risorse dalle contigenze, dal caso e dalle contraddizioni.[7]
Sullo sfondo, l’ipotesi secondo cui questo particolare intreccio di modalità evolutive, altamente instabili e imprevedibili, costituisca una sorta di invariante organizzativo, ossia uno schema formale condiviso da sistemi differenti: storici, biologici, artificiali. Il testo è, al riguardo, abbastanza esplicito:«[…] è necessaria una nuova epistemologia della complessità estrema. […] una volta che l’avremo ottenuta […] non faremo più distinzioni tra sistemi naturali, artificiali e storici, perché ciò su cui metteremo l’attenzione saranno le modalità con cui si evolvono».[8] Tra tutte le tesi discusse in CIS, questa è senz’altro la più interessante e gravida di conseguenze epistemologiche.
11. Direi anche: “la più controversa”. Si potrebbe obiettare che non tutti i sistemi stanno sullo stesso piano. Per quanto raffinati possano essere gli strumenti epistemologici di cui TCE dispone, esistono, infatti, differenze qualitative irriducibili per le quali occorrono trattamenti adeguati e specifici filtri interpretativi. Per esempio: un formicaio e un’orchestra musicale sono creature collettive; tuttavia, si tratta di creature radicalmente diverse. L’organizzazione del formicaio è il risultato di cieche interazioni chemiotattiche tra unità cognitivamente ottuse; l’organizzazione di un’orchestra, invece, no. La differenza essenziale tra formicai e orchestre – e, più in generale, tra formicai e comunità umane – risiede negli spazi di libertà che i rispettivi macro-organismi riservano alle unità componenti. Nel caso del formicaio, questi spazi sono ridotti a zero. Le azioni di ogni singola formica sono il riflesso di chimismi diffusi e reticolari che sincronizzano cooperativamente i movimenti di singole micro-unità di lavoro. Nessuna formica è in grado di sovvertire le regolarità di questi chimismi; ma, soprattutto, nessuna formica è tale al di fuori di essi. Per le comunità umane – orchestre incluse – valgono considerazioni di altro tipo. Senza dubbio, anche in questo caso, i vincoli di sistema esercitano un ruolo essenziale e si può concordare con CIS quando afferma che l’identità di un individuo sia in larga parte plasmata dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, al di sotto di queste significative similarità, lo scenario è radicalmente mutato. Ed è così perché sono diversi i contesti di riferimento: la libertà di azione di cui dispone l’essere umano è incomparabilmente superiore alla libertà nulla di singole formiche interagenti. Beninteso: un uomo può essere condizionato, diretto e orientato nelle forme più disparate. Il suo però resta un modo di agire radicalmente diverso, giacché risponde a vincoli e regolarità organizzative che non sono i vincoli e le regolarità del formicaio. L’epistemologo Pierre Lévy ha chiaramente formulato le ragioni di questa fondamentale differenza. L’intelligenza delle comunità antropologiche, osserva Lévy, sorge da un duplice sistema di vincoli che valorizza sia i contributi delle azioni individuali che i contributi delle azioni collettive. Essa è, in altre parole, doppiamente articolata – o, come ripetono alcuni informatici teorici, glocalica. In un contesto glocalico, le parti componenti, a differenza delle parti che compongono un formicaio, giocano il ruolo di agenti creativi. Si tratta cioè di individui che dispongono di potenzialità bio-cognitive sufficientemente ricche per innovare e trasformare le regolarità di sistema in cui sono immersi. Ogni singolo nodo della rete avrebbe cioè in sé le risorse per modificare l’intera rete – o comunque sue parti consistenti. Fuor di metafora: un agente creativo si distingue da una formica o da una termite per una straordinaria capacità di progettazione che gli permette di istituire inedite condotte comportamentali, suscettibili, a loro volta, di generare nuove regolarità e nuovi vincoli di sistema. Un musicista che suoni in un’orchestra ha sempre una scelta: può rispettare i tempi che il direttore impone ai suoi colleghi oppure – come spesso accade nelle migliori jam-sessions jazzistiche – può improvvisare una performance imprevista e creare dal nulla qualcosa di nuovo. Una formica in un formicaio invece non ha scelta: non può improvvisare nulla e non può emanciparsi dai comportamenti codificati della colonia; può solo obbedire al cieco chimismo del formicaio. Si tratta di banalità, non v’è dubbio; ma sono banalità di cui TCE deve necessariamente tener conto.
12. E infatti ne tiene conto. L’ultimo capitolo di CIS, in cui sono enucleate le principali istanze teoriche di MG, è una lunga e densa riflessione su alcuni temi “caldi” dell’attuale dibattito bio-politico. Il rischio di una “fallacia naturalistica” – tentazione spesso serpeggiante tra le pagine di tanti complessologi – è così neutralizzato da una sapiente e acuta ricognizione sui delicati equilibri che regolano l’azienda e il mercato. La natura del legame sociale è il vero oggetto di riflessione di questa indagine. Azienda e mercato divengono, in altre parole, il nobile pretesto per esaminare criticamente il contenuto di alcune “narrazioni” sulle forme dell’agire umano e sui rapporti che contribuiscono a istituire. Per eseguire tale compito, Licata inforca le “lenti cognitive” del fisico teorico – più precisamente, del fisico dei sistemi complessi. Si tratta di una scelta quasi obbligata: aziende, mercati e collettivi umani sono abitanti della terra di mezzo – e la terra di mezzo è il regno dei fenomeni complessi. Al nostro autore, però, piace remare per il verso contrario. L’adozione di questo punto di vista – che, in realtà, è più punti di vista diversi insieme – diviene una preziosa occasione per criticare dall’interno alcune applicazioni “selvagge” della complessologia all’analisi dei sistemi economici e alle politiche di mercato. Vediamo come.
13. Ci è stato raccontato che i mercati sono dispositivi in grado di autoregolarsi: sistemi capaci di gestire piccole e grandi turbolenze economiche tramite l’attivazione di precise strategie competitive. La magica virtù di queste strategie risiederebbe in un presunto quanto salvifico potere di stabilizzazione: attraverso un sofisticato (e aggressivo) lavoro di estrazione delle informazioni, le aziende, ossia i principali attori dell’autoregolazione economica, assumerebbero l’incarico di risanare le circolarità viziose all’opera nei lunghi o medi periodi di saturazione che attentano alla stabilità del mercato.
Il lessico adoperato per descrivere queste eroiche gesta risanatrici pullula di metafore derivate dalla matematica dei sistemi caotici: gli operatori aziendali agirebbero su domini di transazione “altamente sensibili alle condizioni iniziali” e per di più gravidi di “biforcazioni a cascata”. Da qui una continua ridefinizione degli scenari economici e delle nuove tecnologie di sviluppo. L’antidoto per controllare questi fattori di instabilità endogena sarebbe costituito da una duplice mossa teorica: l’elaborazione di un’adeguata retorica imprenditoriale finalizzata ad un rapido risanamento chirurgico della crisi e la superfetazione dei formalismi matematici. La prima mossa dovrebbe garantire il soddisfacimento dei requisiti di efficienza imposti dalla stabilità del mercato; la seconda invece dovrebbe offrire gli strumenti concettuali per accrescerne l’intellegibilità. La diagnosi di CIS è che sia l’una che l’altra mossa sono il risultato di rappresentazioni falsate – o, nella più rosea delle ipotesi, ipersemplificate. La prima mossa non funziona perché i giochi competitivi tra le aziende si trasformano ben presto in strategie di guerra auto-referenziali che riducono sensibilmente gli spazi deputati all’elaborazione dell’informazione e alla gestione flessibile delle risorse. La seconda mossa fallisce, invece, perché l’impiego massivo di modelli matematici in economia soffre generalmente di un duplice limite epistemologico. Talora, si ha a che fare con modelli eleganti ma empiricamente vacui – ossia astratti costrutti-giocattolo che non catturano le proprietà interessanti dei fenomeni esaminati; talaltra, invece, si ha a che fare con modelli, decisamente più realistici, ma ugualmente inutili perché contenenti un numero talmente alto di variabili e parametri osservativi da risultare poco perspicui o, in alcuni casi, intrattabili sotto il profilo computazionale:«L’uso massivo di modelli matematici in economia ha un po’ lo stesso problema, si tratta di modelli molto eleganti ma totalmente inutili se l’obiettivo è quello di appiccicare un numero a un fenomeno economico. Si è provato a migliorarli, renderli più “realistici”, introducendo più variabili e parametri, ma si resta invischiati in una rete inestricabile di relazioni […] problema che per una teoria che pretende di avere un contenuto empirico forte è l’equivalente dell’andare in overdose».[9] MG è la strategia epistemica che CIS propone per offrire una soluzione plausibile a tali difficoltà.
14. Le principali articolazioni concettuali di MG sono tre e presentano alcune significative affinità con SCCE e AL: a) l’azienda come sistema ecologico; b) l’azienda come dispositivo di progettazione per il futuro; c) l’economia come etica bio-relazionale. Iniziamo con l’esaminare il primo punto. La macchina argomentativa di CIS ha tra i suoi principali obiettivi la decostruzione sistematica di alcune false ovvietà spacciate per evidenze inconfutabili. Una di queste evidenze è che l’azienda si risolva in un sistema di attività esclusivamente finalizzate alla produzione e al consumo di merci. Le vecchie e nuove ideologie della competizione sono da sempre impegnate nella difesa ad oltranza di quest’assunto. Si è sostenuto (e si sostiene tutt’ora) che la principale finalità operativa del lavoro d’azienda risieda nell’elaborazione (prima) e nell’applicazione (poi) di efficaci strategie economiche volte a prevedere i gusti del consumatore o a indurne i bisogni. Un’azienda competitiva, capace di gestire le imprevedibili fluttuazioni del mercato, sarebbe, in altre parole, un operatore sociale che procede, per un verso, alla pianificazione di mosse dirette contro le aziende rivali; per un altro, alla “colonizzazione” dell’ambiente circostante. Questa visione dell’attività aziendale è – secondo CIS – drasticamente riduttiva. Si tratta, infatti, di una descrizione teoricamente grossolana che risulta appiattita su un solo aspetto di quest’attività. Le prime due articolazioni concettuali di MG indeboliscono radicalmente i presupposti di tale descrizione ponendo le condizioni per una visione alternativa della razionalità aziendale. Secondo questa diversa prospettiva, l’azienda sarebbe un operatore sistemico ed ecologico. Rispetto alle interpretazioni che ne enfatizzano gli aspetti “militari” e “produttivistici”, le letture ecologico-sistemiche mirerebbero a rappresentazioni dell’azienda come insieme di strategie strutturalmente accoppiate con l’ambiente e distribuite su livelli integrati di attività che si co-adattano reciprocamente.
15. Il primo tipo di rappresentazioni eredita quest’intuizione direttamente da AL. Grazie a questa strategia epistemica, sappiamo che non esistono condizioni ideali di assoluto isolamento: un sistema, sia a livello di parti costituenti sia a livello di interazioni con altri sistemi, è sempre immerso entro reti fluide di relazioni in cui i confini tra ciò che è interno al sistema e ciò che è esterno ad esso non sono rigidamente fissati. I confini o bordi del sistema sono, in altri termini, flessibili o, per così dire, con un alto grado di porosità. Le ideologie della competizione aziendale lavorano invece su descrizioni ipersemplificate dei bordi sistemici. Queste descrizioni rappresentano l’ambiente come qualcosa di completamente esterno all’azienda. Da qui l’idea – ampiamente corroborata dalla retorica dell’efficienza imprenditoriale – secondo cui esso costituisca soltanto un dominio di appropriazione, una “terra di conquista”:«[…] le campagne pubblicitarie massive e le forme occasionali di mecenatismo sono proprio i sintomi di un rapporto distonico con l’ambiente, come qualcosa di “esterno” che deve essere colonizzato o blandito, una sintonia non naturale».[10]L’esito principale di questa visione è un sensibile impoverimento delle potenzialità dell’azienda, ossia – nei termini di CIS – una drastica riduzione della sua “apertura logica”. La lettura ecologico-sistemica della razionalità aziendale propone invece uno scenario diverso in cui l’impresa, lungi dall’essere un sistema isolato, è in grado di ridefinire finalità e obiettivi del proprio operato in funzione dei mutamenti (politici, tecnologici, culturali) che agiscono sui tessuti profondi della società. La comparsa di questo scenario alternativo si accompagna al secondo mutamento prospettico accennato nella chiusura del paragrafo 14: la rappresentazione dell’azienda come insieme integrato di attività co-adattative. Dietro questa formula apparentemente esoterica, si nasconde, in realtà, un invito chiaro ed assolutamente ragionevole: ripensare l’azienda nell’ottica di un futuro possibile. Gli sforzi di Licata sono, in questo caso, principalmente rivolti a discutere e riqualificare un termine-chiave delle politiche aziendali: “gerarchia”. Letta con gli occhi del riduzionista, questa parola rimanda a una scala piramidale di livelli di controllo il cui apice costituirebbe il principale centro di comando dell’azienda. Si tratta di un’immagine che, per quanto modificata e corretta nel corso degli ultimi anni, non ha mai cessato di sedurre la retorica dell’efficienza imprenditoriale. CIS non suggerisce di accantonarla completamente; propone, però, d’integrarla in un più ampio contesto interpretativo. Entro questo contesto, “gerarchia” si riferirebbe a una rete di risorse informazionali che aggiorna dinamicamente i propri stati sistemici e che integra livelli di conoscenza differenti su uno sfondo comune di reciproche co-determinazioni. I nodi di tale rete informazionale rappresenterebbero il principale “capitale cognitivo” dell’azienda, ossia i centri organizzatori di strategie di progettazione permeabili ai segnali esterni, e, di conseguenza, capaci di delineare nuovi scenari di sviluppo:
La nozione di gerarchia interna richiede una doppia chiave di lettura: da una parte, riduzionisticamente, possia guardarla come un ordinamento piramidale in una catena di comando; dall’altra […] gerarchia è parola che rimanda all’integrazione informazionale tra livelli che si attraversano, comunicano, si modificano assieme e co-evolvono. Se guardo a un’azienda come fisico dei sistemi complessi, quello che vedo è una gigantesca rete di risorse e di conoscenza intessuta da altre reti con dinamiche co-adattative, condizionata e condizionabile da molte varianti interne ed esterne […] Un’azienda non è un bene “statico” […] È un dispositivo di progettazione del futuro. In questo senso l’impresa non è qualcosa che ha confini netti e definiti, ma una rete che riflette il/sul mondo, capace , in base alla propria storia […] di individuare e svelare nell’ambiente scenari efficaci.[11]
Il cerchio argomentativo costruito sulle prime due articolazioni concettuali di MG è così perfettamente chiuso. L’azienda, da attore militare dell’autoregolazione di mercato, si trasforma in qualcosa di radicalmente nuovo: uno dei principali catalizzatori della condivisione epistemica e della partecipazione sociale. L’ultima articolazione concettuale di MG riflette su alcune conseguenze possibili di questa trasformazione.
16. Nel corso degli ultimi trenta/quarant’anni, la riflessione teorica sulla politica e sull’economia ha regolarmente richiamato l’attenzione sulla necessità di reintrodurre un punto di vista etico nell’analisi delle strategie di mercato e nello studio dei rapporti di forza aziendali. È difficile poter valutare l’impatto effettivo di queste operazioni. Spesso si è trattato di invocazioni puramente formali che non hanno mai comportato un serio ripensamento delle categorie e delle strumentazioni concettuali adoperate nella gestione dell’impresa. Piuttosto che modificare il punto di vista dominante della retorica imprenditoriale, questi richiami, quando sono stati fatti, hanno giocato il ruolo di comodi “specchietti per le allodole” con cui ammansire l’opinione pubblica e garantire la pace interna dei consigli di amministrazione. L’ipotesi generale da cui muove la terza articolazione concettuale di MG è che, dietro queste illusioni ad hoc, non vi sia semplicemente un calcolo utilitaristico, ma soprattutto il mancato chiarimento di alcune delle principali nozioni impiegate. Da qui la necessità di un attento esame delle terminologie e dei vocaboli in uso. Per esempio: parole come “competizione” e “cooperazione” sono state frequentemente impiegate in opposizione l’una con l’altra. Le rappresentazioni dicotomiche operanti in questi particolari usi oppositivi hanno determinato (o, quanto meno, contribuito a determinare) una visione profondamente rigida e irrealistica dei rapporti socioeconomici. Si è creduto in particolare che la scelta tra regimi di attività competitive e regimi di attività cooperative non permettesse di mediare tra spinte e tendenze opposte. Una più dettagliata analisi, volta a riqualificare i termini in gioco, ha mostrato che non solo le mediazioni sono possibili ma anche necessarie. Cooperare – osserva acutamente Licata – non vuol dire semplicemente “agire insieme per uno scopo comune”; piuttosto, significa “tener conto delle attività dell’altro”, ossia calibrare i propri comportamenti e le proprie condotte strategiche in funzione dei comportamenti e delle condotte altrui. Definita in questi termini, la razionalità cooperativa non è qualcosa che si oppone aprioristicamente alla competizione: esistono, in altre parole, regimi di attività che non sono né puramente competitivi né puramente cooperativi e che, dal punto di vista delle classificazioni proposte, costituiscono dei veri e propri ibridi. Per questi ibridi è stato coniato un termine, coopetition, che indica come nei rapporti tra competizione e cooperazione sia possibile individuare interessanti terre di mezzo o – per dirla ancora con Licata – “spettri continui” di attività che miscelano condotte dell’uno e dell’altro tipo. In un contesto di coopetition, la lotta competitiva tra aziende rivali, spesso miopi ai profondi mutamenti del legame sociale, è trasformata in un gioco strategico di azioni e co-azioni reciproche le cui principali finalità risiedono, da un lato, nel rafforzamento delle circolarità virtuose che accompagnano la condivisione delle risorse; dall’altro, nella costruzione di luoghi di produzione in cui lo scambio di interessi tra agenti miopi sia rifunzionalizzato in vista di più complesse e articolate unità eco-sistemiche, tra cui l’unità “impresa-contesto”:
Contrariamente a ciò che si pensa, non c’è una dicotomia tra competitività e cooperazione, ma uno spettro continuo per cui è stato coniato il termine coopetition. In questo caso il principio di cooperazione non va inteso semplicemente come “agire insieme per uno scopo comune”. È piuttosto un più raffinato e strategico tener conto delle attività dell’altro, non porsi in modo direttamente e ingenuamente competitivo, ma trovare uno spazio di attività in grado di complementare, affiancare e rafforzare i processi virtuosi in atto in luoghi e contesti anche apparentemente “lontani” dal nodo della rete socioeconomica dove è situata l’impresa.[12]
Le ragioni a favore di un punto di vista etico nell’analisi delle strategie di mercato possono essere rintracciate solo nel contesto di queste valutazioni. Esaminare le dinamiche della vita imprenditoriale nell’ottica della coopetition significa porre al centro dell’attenzione il ruolo costruttivo di “processi relazionali di reciprocità” in cui risiede lo specifico formale di ogni agire etico. La parola “etica” ha così nel lessico di CIS un duplice valore tecnico che può essere ricondotto a due interpretazioni consolidate del dibattito filosofico tradizionale: “etica” come pensiero dell’altro ed “etica” come strategia di riuscita. Le due interpretazioni coesistono nella lettura alternativa che il testo propone di “cooperazione”. Tener conto delle attività altrui presuppone infatti un apparato di competenze stratificate che permettano, per un verso, di considerare l’altro come “fonte di conoscenza” e “occasione di apprendimento”; per un altro, di costruire, sullo sfondo di queste conoscenze acquisite (o “identità di sapere”), una visione più ampia ed articolata del reale che amplifichi le possibilità di successo di un progetto o di un’azione innovativa:«[…] l’esperienza mostra che il comportamento etico è una componente essenziale della vitalità sociale e imprenditoriale. […] l’approccio emergentista […] ne offre una chiave di lettura fortemente legata alla capacità concreta di sostenere e attivare, su tutte le scale, processi relazionali di reciprocità […]».[13]
L’ultimo passo argomentativo di CIS porta a identificare lo scheletro logico di queste capacità progettuali con un insieme di attività interpretative. Gestire e organizzare conoscenze ai fini della progettazione sono tutte operazioni che esigono il riconoscimento preliminare del significato degli eventi con cui ci si misura. Sorprese, contraddizioni e inattesi mutamenti sono, da questo punto di vista, i principali generatori di senso su cui l’etica della coopetizione dovrà scommettere e investire:«[…] bisogna essere capaci di sfruttare l’inatteso, il gap, la contraddizione».[14]
17. Verrebbe infine da chiedersi:«E quindi?». La domanda, sebbene poco educata, è senza dubbio pertinente. I nostri, infatti, sono anni di crisi; nei limiti del possibile, è ragionevole formulare quesiti del genere, ed è altrettanto consentito trasgredire qualche regola di buona creanza. Credo anche però che sia opportuno intendersi sull’effettiva portata degli argomenti in gioco. Un testo come CIS è più unico che raro. Nel giro di poco più di cento pagine, esso offre una panoramica dettagliatissima degli argomenti-chiave di un importante dibattito epistemologico, impegnandosi, peraltro, a sviluppare, nel capitolo conclusivo, un esame articolato di alcune questioni che hanno una forte presa su aspetti fondamentali delle nostre forme di vita.
L’indagine condotta sulle diverse forme di razionalità aziendale e l’analisi delle possibili conseguenze derivanti dall’applicazione di tali forme sull’organizzazione del legame sociale costituiscono senza dubbio un’occasione preziosa di riflessione. D’altra parte, la critica alla mitologia del mercato autoregolantesi fa di CIS un esempio intelligente di analisi militante che, pur adoperando metodi e categorie dell’epistemologia della complessità, assume una certa distanza critica muovendo obiezioni puntuali, non prive di una certa acredine polemica. Il quesito iniziale tuttavia non cessa di riproporsi alla mente del lettore. Su un punto ci sembra utile ritornare al fine di evitare fraintendimenti o pericolosi indebolimenti concettuali. Si potrebbe essere tentati di chiedere alla macchina argomentativa di CIS di risolvere problemi che non spetta a questa risolvere. Dovrebbe essere abbastanza chiaro infatti che il sintetico interrogativo con cui si è aperto questo paragrafo di chiusura, cela domande ben più pressanti e aggressive. È legittimo chiedersi, per esempio, quali siano le concrete linee operative da seguire al fine di realizzare le circolarità virtuose individuate nei regimi di coopetition e nell’unità “azienda-ambiente” che è il principale artefice eco-sistemico di quei regimi. Si potrebbe continuare inoltre domandando in che modo sorprese, gap e mutamenti inattesi possano effettivamente costituire una fonte di ricchezza e di coesione sociale. La lista delle domande potrebbe, in altre parole, estendersi potenzialmente all’infinito e attestare alcune debolezze delle proposte avanzate nel testo. Ognuna di queste domande potrebbe avere più di una ragione a favore e non sarebbe difficile mostrare quali punti del saggio offrirebbero un facile appiglio alle critiche più serrate. Resta il fatto però che non esistono domande valide in astratto. La validità di una domanda – o, come forse sarebbe più corretto dire, la sua opportunità – va valutata contestualmente, ossia in relazione al destinatario. Se il destinatario non è quello giusto, la domanda, e gli scenari alternativi che essa implicitamente suggerisce, decadono. Credo che, nel caso particolare di cui ci stiamo occupando, il destinatario delle domande racchiuse nell’iniziale quesito d’apertura non sia TCE ma la teoria politica. Spetta alla riflessione dei teorici della politica – e aggiungerei dell’economia – farsi carico di risposte adeguate e precise. Il compito di TCE, e delle sue principali articolazioni concettuali (SCCE, AL, MG) è un altro e consiste – come si è cercato di mostrare in queste pagine – nel tentativo di articolare una visione densamente stratificata del reale, che sia attenta tanto alle regolarità quanto alle violazioni di regolarità e che sappia trarre da una commistione di eventi eterogenei delle feconde spinte alla progettualità e alla creazione di nuovi giochi. Da questo punto di vista, TCE, più che il destinario, è la fonte teorica delle domande sollevate – giacché è nelle articolazioni concettuali del saggio che esse si annidano. Si tratta di un mutamento prospettico importante. Se infatti muta il destinatario, muta anche la valutazione contestuale dei quesiti posti, che da “ingiusti” divengono “giusti”. È difficile poter dire quale sia il guadagno effettivo di questo mutamento e non è chiaro fino a che punto sia possibile tenerne conto. Di una cosa però si può esser certi: quando si sanno porre le giuste domande, si è già a metà dell’opera. Forse non è molto, ma è pur sempre un ottimo punto di partenza. Buona lettura.
----------------------------
[1] L’autore di FCP ricorda che l’esatto numero di queste accezioni fosse pari a trentuno!
[2] CIS p. 16.
[3] Ibidem p. 40.
[4] Ibidem p. 21.
[5] Ibidem p. 20.
[6] Ibidem p. 20-21.
[7] Ibidem p. 65-66.
[8] Ibidem p. 23.
[9] CIS p. 115.
[10] Ibidem p. 104. Corsivi miei.
[11] Ibidem p. 106-107.
[12] Ibidem p. 120-121.
[13] Ibidem p. 122.
[14] Ibidem p. 107.